Obiettivo di riflessione: Come creare identità soprattutto quando a chiederlo è una figura professionale come il medico.
Alcuni giorni fa mi ha contattata un medico argentino, già docente di antropologia, per chiedere il mio parere riguardo al concetto di “identità medica”.
La sua richiesta mi ha resa molto felice poiché ha rappresentato una occasione per una riflessione a 360 gradi che ho piacere di condividere con i lettori del Blog “Sulle Ali della Scrittura”.
Mi sono sentita onorata che un medico così lontano da me, abbia preso in considerazione, leggendo alcuni miei interventi e riflessioni, la possibilità di far emergere fra noi un pensiero che implichi un avanzamento nella costruzione di relazioni appaganti di cui, credo, sentiamo sempre più l’esigenza nelle varie istanze sociali che abitiamo. Perché l’identità presume una relazione con sé stessi e con i nostri interlocutori.
Nella parola identità cosa possiamo leggere? Mi verrebbe da pormi inizialmente questa domanda: è un termine che implica inclusione? E se a questa parola affianchiamo la figura di un operatore sanitario, di un medico, che cosa cambia in quella espressione identitaria?
Il termine identità ha un suo significato puro e se andiamo a sfogliare un dizionario ci viene spiegato che per identità si intende il complesso dei dati personali e fondamentali che consentono l’individuazione o garantiscono l’autenticità.
Per accedere ad una individuazione autentica la persona, così come il medico, necessariamente deve produrre un lavoro su di sé, un lavoro che riguarda la sua interiorità, deve accedere alla parte più profonda del sé per sentirsi meno omologato, libero e anche più autorealizzato. Questa identificazione non può, a mio modesto avviso, essere necessariamente scorporata da una buona dose di autostima caratteriale che la si evince tramite un percorso di trasparenza e congruenza con sé stessi.
Il medico, proprio per il lavoro che svolge, ha bisogno di fare trasparenza in sé stesso, di elaborare il suo vissuto per riuscire ad introiettare con empatia e dolcezza la fragilità del paziente, la fatica della persona che ha di fronte, le paure (e le paure del medico quali sono?) legate alla malattia della persona.
Se troppi nodi e fragilità interiori inficiano l’equilibrio mentale e fisico dell’operatore sanitario, elementi discordanti volti alla cura si frappongono in questo tramite della relazione che aumenterà la sua portata di disorientamento fra i due soggetti.
L’utilità del confronto sta sempre nel rispecchiamento perché specchiarsi nell’altro garantisce una possibilità di cura maggiore; è come se il paziente si sentisse protetto ed ancorato ad un punto di riferimento solido, essenziale per credere maggiormente nella cura somministrata, nelle proprie capacità terapeutiche.
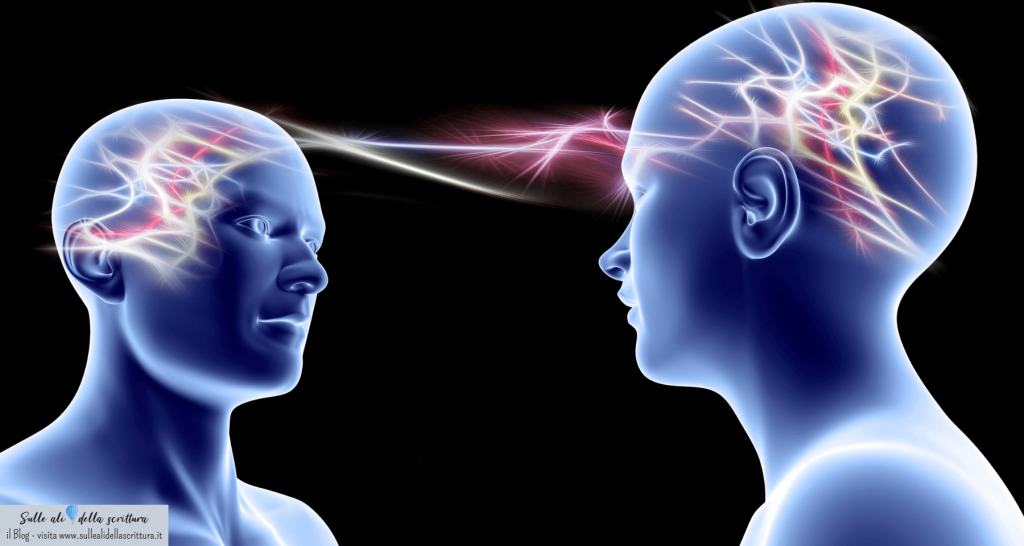
Per entrare nella storia dell’altro, nella sua narrazione, dobbiamo imparare dapprima ad ascoltare noi stessi, ciò che ci turba, le nostre fatiche, per riuscire a fare un lavoro di cauterizzazione sulla ferita attraverso l’emanazione della parola.
Per renderci persone fedeli a quel paziente e alla sua storia, come operatore sanitario devo obbligatoriamente fare pulizia dentro me attraversando i miei lutti, le mie fragilità, le fatiche della mia professione. Senza parola rinfrancante e terapeutica difficilmente riusciamo a trovare conforto e a riconciliarci con quelle parti di noi inevase e che sono state a lungo anestetizzate senza trovare il coraggio di una elaborazione costruttiva e conciliante verso le cose del mondo. Introiettare troppa sofferenza o dolore personale non ci rende immuni al dolore dell’altro, anzi a volte ci difendiamo dal dolore della persona trincerandoci dietro un’aureola di perbenismo e mediocrità.
I medici in tal senso dovrebbero essere maggiormente coesi fra loro imparando ad aiutarsi l’uno con l’altro nell’ascolto reciproco, gli operatori in tal senso dovrebbero costruire incontri settimanali dove poter condividere le proprie storie di vita e di conseguenza, poi, anche quelle dei pazienti.
Gli operatori dovrebbero sentirsi sollecitati a salire una scala che è quella della conoscenza imparando a superare pregiudizi personali spesso nutriti verso un collega o un superiore e lo stesso vale per i giudizi che la persona spesso esercita su di sé, perché queste due sovrastrutture mentali non permettono una crescita più ampia e un’ascensione verso la comunicazione aperta e libera.
E la comunicazione è tassello importante nella relazione ed è maggiormente proficua se per scelta ci permettiamo di entrare nella nostra storia e in quella dell’altro avendo sempre a mente che conoscere l’interiorità, la profondità dell’individuo è sempre crescita personale e creazione di coesione comunitaria. Rispecchiarsi nella storia dell’altro è sempre isola felice fra gli individui e su questo tema bisogna fare formazione perché ne siamo ancora lontani. Posso darmi la possibilità di conoscermi attraverso l’esperienza umana che è sempre formativa e imparo a misurare le mie capacità di apprendimento tramite la testimonianza di chi mi è accanto.
La condivisione di gruppo aumenta le risorse e gli equilibri vicendevoli e diviene sostanza vitale perché attraverso la nostra sofferenza impariamo a riconoscerci maggiormente nella storia dell’altro e a mettere a fuoco le asperità e le nostre fatiche.
Ogni settimana quel gruppo dovrebbe regalarsi un paio di ore per imparare a autosostenersi entrando nei propri nodi, nelle fragilità, nella memoria sopita e resa inenarrabile, difficilmente elaborata perché più il tempo passa più la si teme. Quello stesso gruppo potrebbe godere di un tempo interiore anche dando voce ai rapporti affettivi che ci autodefiniscono, anche a loro va data voce per imparare a tracciare una direzione di sostentamento e di equilibrio relazionale.

Il gruppo potrebbe aiutarsi anche attraverso la pratica lodevole della scrittura con un coach che ne detta le direttive; scritture che permettono questa adesione del corpo alla nostra identità e di relazionarci in modo più consapevole e compensativo per i vari partecipanti del setting.
Il maschile, come sappiamo, tende più facilmente a proteggersi da questa natura espansiva perché teme di essere toccato, giudicato, in uno spirito di competizione che prevale sempre nei diversi ruoli professionali e che non è forza includente ma disgregante. Una competizione che si fa fatica a snaturare ma devo anche aggiungere che molte cose della nostra vita stanno modificandosi e maturando e anche qui arriveremo ad una meta propiziatoria con passi giusti.
Il maschile e forse maggiormente alcune professioni dedite alla Cura, rimangono più incastrate dal ruolo professionale abdicando alla bellezza e rinunciando alla funzionalità dell’essere, al sentirsi uomini che crescono nei sentimenti, alla grande risorsa dell’empatia, alle emozioni che fanno parte di un bagaglio culturale da considerare egregio nel suo valore. Senza espressione del sé facilmente perdiamo la parte più autentica di noi, i nostri talenti, le ambizioni protettive, l’identità come forza in cui riconoscersi. E poi su un concetto base dobbiamo trovare la forza di insistere e farlo diventare emolumento di una sana educazione anche universitaria. Tutte le fragilità che caratterizzano l’uomo sono sempre caratteristiche legate alla forza del carattere, perché si cresce veramente con la caduta, attraversando la sofferenza, sporcandosi le mani, venendo a patti con noi stessi, non dandosi alla fuga. Per stare con il sé dobbiamo confidare profondamente nell’essere umano, nelle sue capacità e nella sua autorealizzazione che è maggiormente significativa se è legata ai propri sentimenti, al proprio desiderio.






